10 Ott No Gender | Claudia Vanti
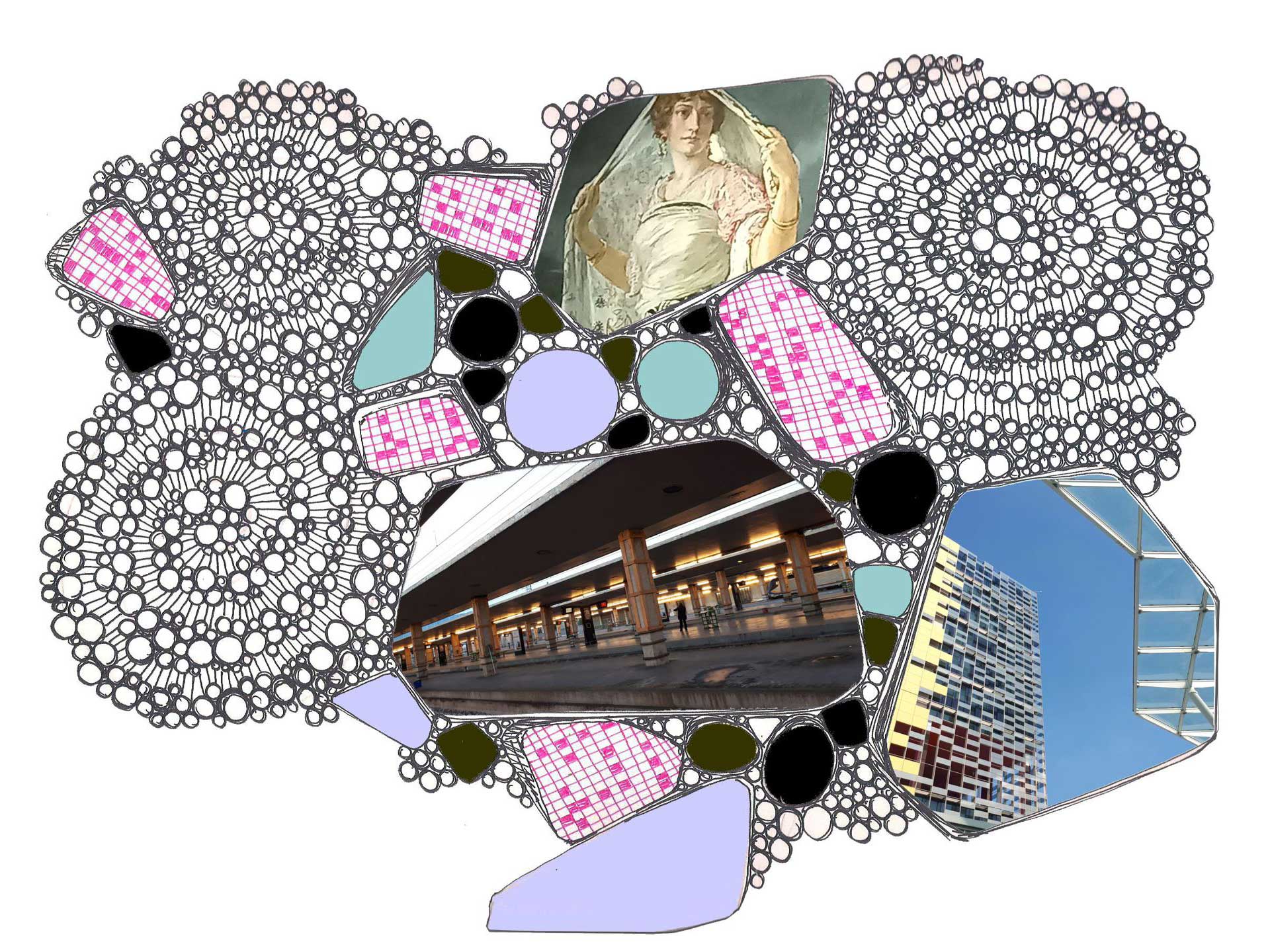
Finite le sfilate si è continuato a parlare molto di moda perché improvvisamente ci si è accorti che la stragrande maggioranza dei direttori artistici delle collezioni sono uomini e nello specifico uomini gay cis bianchi.
Non che fosse una novità, anzi, è un dato di fatto da tempo e soprattutto da quando le maison non sono più marchi indipendenti ma proprietà di grandi gruppi finanziari.
Il casus belli del momento è l’avvicendamento chez Alexander McQueen con l’addio di Sarah Burton e l’arrivo di Seán McGirr: Sarah è molto amata, si è fatta carico di una transizione non facile dopo il suicidio di Lee McQueen e ha portato il marchio ad avere un’identità propria con l’ossessiva ricerca di una perfezione sartoriale che non ha scontentato neppure i fan della prima ora, pur “orfani” del genio immaginifico del fondatore.
Ma a parte la fuoriuscita di Sarah Burton (che fra l’altro è parsa più soft di molte altre – baci e abbracci con il presidente della Holding, comunicati stampa ben oltre il dovuto istituzionale e, da parte sua, un ottimismo verso il futuro che forse annuncia qualche altro incarico prestigioso), la questione è che sembra che alle donne sia riservato un numero limite di posizioni apicali nel mondo moda: per esempio, proprio in casa Kering – proprietaria dei marchi McQueen, Balenciaga Saint Laurent e molti altri – nel momento in cui la manager Francesca Bellettini è diventata la referente di tutti i brand (è la vice della proprietà, in pratica) quasi per la legge del contrappasso è uscita l’unica direttrice artistica donna a libro paga.
Maschilismo puro e semplice o altro?
Il luogo comune abbracciato con gioia anche da tanti addetti ai lavori che in teoria dovrebbero essere un attimo più smaliziati rispetto alle dinamiche del mondo moda è che il designer uomo sia più visionario e la donna più concreta, quindi, detto esplicitamente, meno innovativa e con un occhio alla portabilità dei capi che, se per alcuni è un à tout importante, per altri rischia lo sconfinamento in una ripetitività che non suscita desiderio.
Un classico uroboro.
Al di là del maschilismo sostanzialmente imperante in tutto il mondo moda e soprattutto (chissà perché – uh, che meraviglia!) in Italia e che meriterebbe una trattazione pressoché infinita, la presunta inadeguatezza delle stiliste al delirio in forma visionaria è principalmente espressioni di board e direttive aziendale che alle donne richiedono proprio uno sguardo più incentrato sulla portabilità dei capi che sull’innovazione.
Insomma, praticamente decenni di collezioni di Rei Kawakubo, Vivienne Westwood o, andando ancora più indietro, di Elsa Schiaparelli, gettate nel dimenticatoio per la ricerca di una “vestibilità quotidiana” che già solo a pronunciarla diventa noiosa.
Quello che è strano però è che questa over presenza di designer uomini avviene proprio in un momento dove nessuno, ma proprio nessuno, ha rischiato più di tanto (nulla) e le collezioni noiose – almeno questo in questo caso con una certa parità tra i generi – le hanno proposte sia gli uni che le altre.
